Pirilla? What’s pirilla?

Lunedì – 17 Agosto 2009 – Parco San Vito – ORTELLE – 29^ edizione
Figlio e nipote di furnare (fornaie), che ha passato più di una notte da bambino a dormire sulle sarcine (fascine di rami) o nelle matthre (madie) avvolto dai sacchi vuoti della farina per non essere lasciato solo a casa, e fatto tante colazioni a pirille calde, quando mi chiedono cos’è una pirilla ci resto sempre male.
In effetti non è semplice saperlo, perchè la pirilla in fondo è solo farina, lievito e un po d’acqua, ma non è il pane. E’ il resto di quello che non si voleva (o poteva) scartare dal complesso processo della panificazione. Un processo lunghissimo che prima della meccanizzazione dell’agricoltura (piuttosto recente nel Salento) partiva dalle sementi dell’anno prima, dalle arature coi cavalli, poi le semine, la falciatura a mano, la trebbiatura con le bestie sulle aie e infine con la macinazione per la farina.
Ogni famiglia, se poteva, produceva grano per consumo proprio e il poco di più si vendeva o si scambiava.
Con la farina macinata fresca, anche un paio di quintali per volta e secondo la capienza del forno, una famiglia o più parenti, si organizzava per panificare la scorta di pane per uno due mesi in avanti.
Il pane fresco, i filoni, le rosette, i panini, arrivarono solo nel dopoguerra e prima di allora bisognava congegnarsi a produrre il viatico per la tavola e le colazioni nei campi senza la comodità dell’acquisto quotidiano.
Chi poteva, in genere benestanti che avevano il comodo del forno di proprietà, panificava poco e spesso avendo sempre pane fresco, chi invece non poteva affittava il forno pubblico di cui in genere ogni centro salentino disponeva a sufficienza e si ingegnava.
Il forno pubbico, in genere un unico ampio vano con un forno in pietra sul fondo, era prenotato per tempo. I maschi si incaricavano di macinare il grano e portarlo nel pomeriggio tardi al forno. Per l’occasione la farina era contenuta in sacchi ancora più puliti e pregiati di quelli per il grano. Erano quasi sacri e ogni volta lavati.
Alla stessa ora coi rimorchi o i traini si portavano le fascine per riscaldare il forno. Negli ultimi anni erano esclusivamente fascine di rami di ulivo della rimonda (munna, munnatura) ma ancor prima si bruciava di tutto (sterpaglie, spine, rovi, sottomacchia, ecc..) perchè i rametti di ulivo erano riservati alla pentola (cazzarola) di casa, almeno fino all’arrivo delle prime cucine a gas.
Per una quantità (cotta) di due quintali di farina potevano servire dalle sei alle dieci fascine di ulivo da circa quindici chili di peso l’una. Molto dipendeva dalla temperatura del forno dopo la panificazione precedente e ci si organizzava appunto da avere sempre il forno in caldo senza nessun giorno di interruzione in mezzo.
Tra chi panificava prima e chi il giorno dopo, ci si scambiava le solite cortesie. Si lasciava il forno pulito, gli attrezzi in ordine e sopratutto il lievito per la fermentazione del pane. Il lievito fresco vero e proprio doveva essere acquistato e conservato al fresco ed era cosa complicata, per cui chi lasciava il forno teneva da parte per chi entrava un po di pane fermentato (non cotto) che, aggiunto all’impasto della farina con l’acqua, facesse da nuovo lievito alla fermentazione. Si chiama criscente (crescente) e l’effeto più visibile era proprio quello di far crescere il volume degli impasti nel giro di un paio d’ore. L’effetto era notevole.
Il forno era sempre dotato di una camera di cottura più o meno grande, sempre a pianta circolare con volta a cupola ribassata, con fondo e volta in genere in pietra leccese.
Cuocere era un’arte. Bisognava conoscere le caratteristiche termiche di quel forno in particolare. Se teneva il calore dei giorni prima, se bruciava più di volta che di fondo, se raffreddava (calava) troppo con l’infornata fresca. Sbagliare la cottura non era permesso. Chi conosceva i segreti dei tempi, degli impasti e del forno, aveva un mestiere sicuro e nonostante l’orario di lavoro infame alla fine portava a casa un po di lire e pane fresco da mangiare.
C’erano sempre un paio di tavoli di legno nudo, uno per lavorare in piedi la pasta fermentata (scanatura) e uno per la fornaia che seduta confezionava i pezzi da cuocere.
Una cisterna col secchio per l’acqua da usare nell’impasto, un paio di madie (matthre), in pratica dei cassoni in legno in cui in una perfettamente stagna si impastava tutta la farina col lievito (o il crescente) e si lasciava poi protetto dai sacchi un po al caldo per lievitare; nell’altra si poggiavano i grossi pezzi di pasta lievitata dopo la fermentazione.
La cosa che più colpiva di un forno a legna erano le attrezzature per la cottura. Forconi, palette dai lunghissimi manici, scoponi e i tavolami per riporre i pani prima e dopo la cottura. Erano a mensola su qualche comoda parete e dovevano essere sfilabili e trasportabili alla bisogna. C’erano dei ripiani fissi per poggiare i sacchi della farina, dei sedili fissi e al massimo un paio di sedie.
La quota della volta della camera di cottura era in genere molto più bassa dell’ambiente in cui era ricavato, per cui al di sopra del forno di cottura principale era ricavato un secondo fornello (forneddhru) non alimentato se non dal calore del forno principale sottostante. Era una camera chiusa con porta e serratura molto calda. I venditori di noccioline della zona ci lasciavano sparse per terra le arachidi e le noccioline per ravvivare la prima tostatura e tirarne via un po di umidità in occasione di qualche nuova festa. Pure ci lasciavano legumi, fave, cereali, tutto quanto avesse bisogno di una nuova seccatura.
La panificazione si svolgeva rigorosamente a porta chiusa ed era cosa per donne. Il maschio era tollerato per spostare i sacchi pesanti, le matthre e infilare le fascine nel forno. Le fascine, lasciate nel pomeriggio fuori dalla porta sulla strada, erano portate all’interno per evitare sia problemi con le piogge sia per non aprire e chiudere la porta dell’ambiente di lavoro. Ne poteva risentire la fermentazione, la temperatura del forno e la salute dei presenti. Si evitava pure che il chiacchiericcio si spargesse per la strada.
I tempi erano lunghissimi, quasi un giorno intero. Dal trasporto al forno della farina e della legna al trasporto a casa del pane passavano quasi 24 ore. Si producevano più tipi di pane: una quota di pane fresco per il consumo massimo di una o due settimane e il resto di pane secco (friseddhre) che durava anche mesi.
Essendo il pane secco difatti un biscotto (cioè cotto due volte) le cotture erano ogni volta non meno di due.
Nel pomeriggio tardi si impastava la farina, ci pensavano la fornaia e una di casa. Si controllava che la legna fosse secca e a sufficienza. Si copriva l’impasto per tenerlo caldo e si lasciava il forno vuoto e chiuso.
A casa si organizzava il resto dell’attività secondo i gusti e la pazienza di chi panificava. Qualcuno si spiziava per fare pane con olive, pezzi di zucca, taralli e allora si preparava gli ingredienti per tempo. Si preparavano coltelli e tovaglie per avvolgere il pane caldo e tutto si metteva nelle panare (ceste di canne) che al ritorno dal forno avrebbero consentito il trasporto del pane ancora caldissimo.
All’ora convenuta, spesso già buio, marito, mogli, sorelle, cognate e vicine di casa erano al forno. Il maschio accendeva il forno, le donne, almeno in cinque o sei, tiravano fuori i pani che in un paio d’ore erano lievitati e cominciavano ad amalgamarli, appallottolandoli e poi sgranandolo, in una paziente operazione che doveva evitare la presenza di grumi nell’impasto e favorire alcune proprietà dell’amido.
La vista di quelle manipolazioni, dei grossi seni femminili tirati su dalle braccia ravvicinate e le oscillazioni dei busti per fare forza sulla pasta aveva qualcosa di conturbante. E non era raro che, nonostante la presenza di qualche maschio o bambino, la conversazione tra le donne prendesse la strada del pettegolezzo o della sconceria.
Il mostro del forno era la vampa. Quella lingua di fuoco che quando le fiamme si attizzavano di colpo dopo essere scemate riprendevano vigore. Un po per gioco e un po perchè le cose non andavano come previsto, le fascine infilate nella bocca del forno non prendevano fuoco all’istante ma nell’aria satura di fumi stentavano a bruciare. Per cui dopo qualche secondo, quando la camera ricambiava l’aria dai fumi e la legna era ormai oltre il punto di autocombustione, il fondo del forno si rabbuiava di un rosso cupo e profondo e il mostro era pronto ad uscire. E appena l’addetto dava l’allarme una lingua di fuoco a volte anche di un paio di metri, usciva dalla bocca ad abbrustolire ciglia e capelli di disattenti sventurati.
Il pane, perfettamente impastato, era ridotto a pezzi. Cucule per il pane molle, cucule per i panetti (un pane di pasta più fine senza bolle di più lunga conservazione e buono da grattarsi per la rimanenza). Una parte dell’impasto si rimetteva in grossi vasi smaltati (i limmi) per miscelarlo con olio per i taralli (cuddhura) con olive, pezzi di zucca (cucuzzate).
La quota più grossa di farina era generalmente destinata al pane secco. Per questo scopo i pezzi erano delle lunghe losanghe alte sei sette centimetri, lunghe trenta e spesse due. Si passavano alla fornaia che con le dita ne schiacciava l’asse più lungo e le arrotolava ad involtino. Queste rosette erano poste una affianco alle altre sulle tavole su un letto di farina per non attacarsi sul fondo. Giacchè la lievitazione continuava pure dopo l’impastatura questi singoli involtini accrescendosi finiva che si attaccavano tra di loro in modo caratteristico.
Quando il pane era tutto pezzato e gli impasti dei pani speciali quasi pronti, la fornaia si alzava dalla sedia del suo tavolino e prendeva il comando del forno. Nonostante fosse un gesto ripetuto per anni per il forno si spargeva una evidente tensione. Mentre si dava una rassettata e si cacciava via quanto non servisse più, la fornaia controllava nervosamente la temperatura del forno. Per anni, anche per me, è stato un mistero. Ricordo mia nonna o mia madre comandare un tot di ricarica di legna in più guardando il colore della pietra leccese delle pareti. Bruciare o non cucinare il pane era una grossa responsabilità. Per questo ogni forno aveva la sua fornaia e viceversa.
Negli utimi anni, quando ormai era chiaro che quel mondo andava ormai sparendo, mia madre cominciò a confidare qualche malizia. Una che mi ricordo era come sapere se il fondo del forno avesse raggiunto una data temperatura. Quando ci si accingeva a pulire per bene il fondo del forno dalle ceneri per poggiare sul pulito il pane si dovevano vedere le scintille! Si utilizzava uno scopone con attacati rami di alloro o di fracilische (più fini), continuamente bagnato perchè altrimenti prendeva fuoco. Una volta pulita la chianca si notavano effettivamente le scintille. Altro non erano che il minuscolo pluviscolo del legno che poggiandosi sulla chianca andava in autocombustione. Se la temperatura era raggiunta il pulviscolo si infiammava producendo un caratteristico scintillio. Altrimenti si ordinava una opportuna ricarica di legna.
Il forno poi era pulito, scopato e su un lato, in una piccola fossa appena dopo la bocca, era lasciato un fuocherello per dare luce e in certe fasi, sovralimentandolo, per dare colore alla faccia superiore del pane. Aiutava appunto a regolare la temperatura della volta del forno per evitare di bruciare il fondo del pane attaccato alla chianca senza aver cucinato l’interno o il sopra della pasta.

Pulito il forno, si cominciava a infilarci dentro il pane. Con ordine. Prima i blocchi appiccicati di involtini del pane secco, poi i pani ed i panetti, poi il pane speciale e poi un po di posto di libero. Tutto era sistemato secondo l’ordine di sfornatura.
What’s Pirilla?
Finito il lavoro, si lavavano le madie e i limmi raccogliendo dai fondi e dalle pareti una pastina di farina lieviata, di una consistenza appena più dura della pastina delle crepes, la si faceva scolare con la mano sulle pale dell’infornatura e si colavano sulla chianca del forno. L’impasto molto liquido si schiacciava e si arrotondava perfettamente da solo e si cucinava, essendo sottilissima, di tutta l’infornata, per prima.
Chiusa la bocca del forno con la pesante pacenzia (pazienza) in ferro, ormai a notte tarda, ci si rilassava. Molte donne tornavano a casa a dormire. Ma prima si tiravano dal forno le pirille già cotte e con o senza companatico si mangiavano perchè ormai c’era appettito. Pirille con le olive, o tagliate un due e riempite di tutto, vino, saluti e buonanotte.
Il pane molle e i panetti venivano tirati via appena cotti e posti nelle panare tra le tovaglie perchè trasudassero il resto dell’umidità dell’impasto. Gli “involtini” di pane secco (friseddra) erano tirati fuori, staccati tra di loro e poi con una corda strangolati nel mezzo lungo il solco già impresso sulla lasanga molle dalla dita della fornaia. Per questo le friseddhre sono diverse.

Ci sono quelle che hanno il fondo (u culu) appiattito dalla chianca e quelle che hanno il fondo tondo che appunto si era conservato senza nessun contatto verso l’alto nel forno. Tutti e due i tipi hanno la faccia comune del taglio dello spaghetto.
Le diverse centinaia di pezzi ottenuti dal taglio, una volta ravvivato il forno con nuova legna e riscopato, vengono rimesse a cottura fino a che si riducono a un duro biscotto molto secco che sbattuto sulla chianca non canta bene.
Gli effetti combinati della doppia cottura crea un incipiente scollamento tra il fondo (sutta) della frisella e la faccia superore (susu) per cui anche la metà cacciata per la seconda volta al forno e possibile dividerla facilmente in ulteriori due parti: una più dura e una più morbida. Una volta bagnata con l’acqua per mangiarla, l’effetto è ancora più evidente.
Tra le pause delle cotture si poteva pure tornare a dormire un po, e poi raccolti i pani e le friselle nei panari, si puliva il forno e si passavano le chiavi al nuovo arrivato che già si premurava di scaricare le fascine e la farina.
A casa si smerciava un po di pane tra aiutanti e parenti, e si sistemava il pane secco, lasciato traspirare un po, nei quartieri (capasoni).
What’s Pirilla?
Pirilla è un mondo che ormai non c’è più e che non tornerà più.
E ventinove anni fa, quando ancora l’ultimo forno pubblico in via Diaz fumava ogni notte, la paura della scomparsa di quel mondo spinse gli ultimi fornai a fare una infornata di pirille e regalarle su Piazza San Giorgio.
Da ventinove anni si ricorda un mondo che in poche parole non è possibile spiegare. Perchè la pirilla non è un tipo di pane, e, se pure, in vita sua non è mai uscito da un forno.
Non la troverete nelle panetterie e se ve ne faranno mai omaggio è solo per chiedere una preghiera ai cari che non ci sono più.
La Pirilla, col suo buffo nome, è la nostra passata giovinezza e spiegarla fa sempre un po male.

Pirilla – s.f. – Pane ottenuto con impasto lievitato di acqua e farina di grano duro. Ottenuta per colatura diretta sulla pietra di un forno a legna con l’aiuto di una paletta. Ha una forma rotondeggiante di circa 20 cm di diametro e pochi centinetri di spessore, presenta la faccia superiore liscia, quasi levigata, dura ma non croccante. La pasta interna ha un aspetto compatto e quasi gommoso con piccoli alveoli (non una piadina). Richiede brevissimi tempi di cottura.
Nella pasta, specie se nata per essere mangiata senza condimento, possono essere inserite olive nere intere per dare sapore. Lo spessore e la pasta compatta permettono un comodo spacco per la farcitura. La farcitura più usata era il pomodoro fresco, spesso solo il seme e gli umori interni del pomodoro, olio e sale. Pure peperoni fritti, a volte pure accompagnati da pomodoro fresco. Vanno molto bene le farciture che bagnano la pasta e l’ammorbidiscono un po, come i sughetti di pomodoro, cipolla e peperoni ma pure i pezzetti di carne di cavallo. Una variante sfiziosa della farcitura sono i peperoni fritti con fette di mortadella.
Presenta vari sinonimi nel Salento i più usati sono pirilla e pitilla.






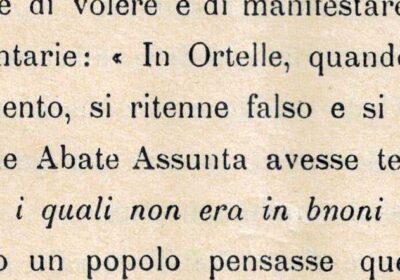







Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.